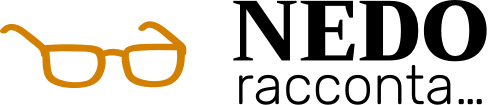I quattro casamenti popolari “a riscatto” accanto al Calambrone, sembravano delle costruzione della Lego messi lì per caso, estranei a quel luogo. Un misto di campi agricoli e case popolari. Lo stadio di San Giovanni non esisteva e la chiesa di San Pio X era ancora “la chiesina” in un angolo della piazza del Calambrone così piccina che Don Martellini quasi non c’entrava.
Viale Gramsci era appena nato con degli alberelli secchi secchi che accentuavano il senso di periferia. Su tutto vegliava più lontano l’imponente muro dell’Italsider o meglio della “Ferriera” come ancora oggi viene chiamata, che dalla fine del viale arrivava fino alla Stazione.
La sirena della Ferriera scandiva il tempo di San Giovanni, con l’inizio e la fine dei turni di lavoro degli operai dalle 6 alle 2 del pomeriggio, per arrivare poi alle 10 di sera. Infine c’era il turno di notte dalle 10 alle 6, lungo e buio. In questi intermezzi la Ferriera però non era in silenzio. Si sentivano clangori di ferro, pezzi che cozzavano gli uni sugli altri. Sbuffi del fuoco dei forni. Era il respiro del paese.
Quel giorno d’estate, rovente anche allora, fu una sorpresa per noi.
“Il Babbo oggi torna prima dalla ferriera” disse la mamma “andremo a fare il bagno all’Arno”.
Non riuscivo a smettere di sbirciare tra le stecche delle persiane, perché in casa tutto era in penombra. Fuori non si muoveva niente. Il sole rovente infiammava il cemento della discesa che dalla strada portava alla porta d’ingresso del casamento. I campi dove il grano era stato falciato di recente, sembravano distese secche senza vita.
La mamma era in cucina che stava preparando qualcosa, Anna, mia sorella più grande giocava in camera. Mi distesi sul pavimento del salotto con le braccia aperte. Ero in mutande e con la mia canottierina bianca, cercavo refrigerio nelle mattonelle di graniglia mentre la danza di due mosche sopra il lampadario attraeva la mia attenzione.
Fu il rombo inconfondibile del “Macchi 150” del babbo a destarmi. Era arrivato finalmente e mi precipitai ad aprire la porta mentre lo sentii salire le rampe delle scale fischiettando.
Sorpresa nella sorpresa fu quel cocomero che portava sottobraccio. Bello verde, appetitoso. “Lo mangeremo stasera, vedrai, bello fresco” e mi dette un bacino spettinandomi i capelli.
La mamma aveva già preparato la borsa con gli asciugamani e un altro borsone che non capii bene a cosa servisse.
Dopo poco uscimmo e a piedi ci incamminammo verso l’argine. Prendemmo una strada sterrata che conduceva all’Arno passando davanti a una casa di contadini. La statale 69, “la circonvallazione”, rappresentava un argine ulteriore. Pochi anni dopo, la
notte del 4 Novembre del 1966, ci avrebbe un po’ salvato dalla furia della piena.
I sassi bianchissimi sulla riva ci accolsero come una spiaggia del mare.
Il fiume invece offriva vari panorami. Più a nord verso la pineta si abbassava e si strettiva. Si formavano allora delle ampie e veloci rapide. “Lo stroscio” come si chiamava e si chiama ancora.
Lì l’acqua era come si depurasse, come sorgente fresca, più sotto impetuosa rallentava e sprofondava, formando qua e là piccoli gorghi. “I mulinelli”, solo a nominarli mettevano a noi ragazzi paura. Per non farci andare in quelle zone, narravano di trascinamenti verso il fondo più oscuro, di affogamenti, della forza dell’acqua senza possibilità di resistenza alcuna. Io dalla riva li guardavo, affascinato e inorridito, mentre qualche foglia galleggiante veniva trascinata giù dopo ampi giri, in caverne e anfratti per me misteriosi e tremendi.
Ci sistemammo vicino alla riva in una zona dove i sassi facevano uno scalino. La mamma stese gli asciugamani mentre il babbo andò a sistemare il cocomero proprio sullo “stroscio” fermandolo tutto intorno con dei grandi sassi. L’acqua lo lambiva e lo ricopriva lesta e frasca, più tardi sarebbe stata una leccornia.
L’acqua era limpida e ci incamminammo fin dove si toccava con il babbo che ci teneva per mano. Forte e rassicurante non evitò però che scivolassi sul muschio del fondo che si era depositato sui sassi. Andai sotto e fra le risa mi ritirò fuori. “Piano piano imparerai a nuotare” disse il volto sorridente del babbo. Detto fatto mi prese per la pancia e mi
mise orizzontale all’acqua. “Vai ora ruota le braccia e batti i piedi”. Iniziai ia farlo goffamente e quando lasciò la presa finii per affondare velocemente. Nonostante questo mi fece riprovare varie volte e alla fine un po’ ce la feci a restare a galla. Qualche settimana più tardi sarei riuscito a imparare e l’Arno rimarrà per sempre la mia scuola di nuoto.
Ma che bello, che divertimento. Tuffi dai massi più grandi, schizzi e poi ad un tratto non so come il babbo tirò fuori una vecchia camera d’aria.
Con una pompa di bicicletta che evidentemente si era portato dietro, la gonfiò e con fare misterioso disse. “Ora inizia l’avventura”. Infilò me e mia sorella dentro a questa specie di ciambella, ci mise in acqua, salutò la mamma che aveva paura dell’acqua e non ci metteva neanche un piede (e mai ce lo metterà in seguito), e piano piano ci portò dall’altra sponda dell’Arno, quella profonda, per noi bambini oscura e irraggiungibile.
L’Arno laggiù diventava un universo inesplorato; le acacie o meglio le “casce” come si chiamavano noi, crescevano rigogliose sulla sponda e reclinavano le chiome fino a toccare l’acqua formando un tunnel tanto ombroso quanto oscuro, affascinante e spaventevole.
L’acqua lì quasi si fermava, diveniva scura, profonda. Il silenzio regnava dentro alla penombra degli alberi mentre la prova di coraggio era mettere le mani sotto l’acqua, sulla parete della sponda che sprofondava. Ogni tanto una piccola grotta si percepiva al tatto e in fondo ad essa la mano si ritraeva veloce se scopriva la pelle liscia e viscida di un pesce, chissà una lasca, un’alborella o forse un’anguilla.
Poi finalmente uscimmo e ritornammo a riva. “Guarda le dita tutte raggrinzite, siete stati troppo nell’acqua” e via sotto gli asciugamani a strofinare i brividi sulla pelle che confermavano quanto detto dalla mamma.
Poi il borsone del quale ignoravo il contenuto, si rivelò. Uscì fuori la cena. Che meraviglia avremmo mangiato sui sassi dell’Arno. La mamma aveva preparato le “bracioline” fritte, con i pomodori verdi, fritti anch’essi. Mi parve il pranzo più bello e più buono del mondo. Anche l’appetito mi parve il più grande che avessi provato. Alla fine il cocomero fu tagliato. Nettare puro, ambrosia, frutto delizioso che concluse degnamente il pasto . Sul far del tramonto, quando la luce del giorno cede pian piano alla sera e tutto sembra divenire magia, il babbo prese dei sassi piatti. Si mise sulla sponda dell’Arno, posizionò il sasso tra il pollice e l’indice, si abbassò un po’ piegando le gambe e con gesto ampio lo lanciò parallelo all’acqua.
Che bello il sasso rimbalzò sulla superficie una, due, tre, quattro, cinque volte e ancora un altro. Una due tre, poi tante da non contarle fino ad arrivare all’altra riva. I cerchi che si formavano sull’acqua rompevano il rosso meraviglioso del cielo che si rifletteva su quello che in quel momento era il mio mare, mentre la mia anima viveva un giorno di vacanza indimenticabile.
Oggi mentre i miei capelli bianchi sono mossi dalla bellissima brezza della Sardegna e dinanzi ho le meravigliose trasparenze del mare della Maddalena, cerco ancora i sassi più piatti e li lancio lontano sull’acqua. Uno due tre quattro, che strano i cerchi sull’acqua creano della forme particolari mi è sembrato di vedere laggiù una ciambella con due bambini e un babbo che li spingeva; sarà stato un gioco d’ombre del sole che sfiora l’acqua o forse il cuore che con il tempo del vita rovista sempre più nei ricordi più belli e fa umidi gli occhi.